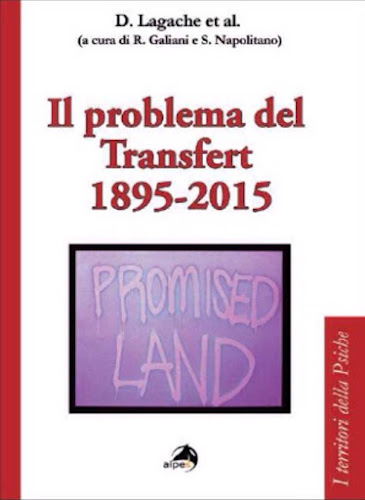Undici poeti contemporanei, di differente età, estrazione e provenienza geografica, ciascuno presente con dieci poesie, introdotti da un lungo saggio critico. Questa la formula di Orme poetiche, l’antologia da poco pubblicata da Intermedia e già presentata al Salone Internazionale del Libro a Torino, oltre che in varie parti d’Italia (tra cui Paliano, Samone, prossimamente il Salento). Ne parliamo con Cinzia Baldazzi, che ne ha scritto l'introduzione. Autrice di saggi e articoli di carattere letterario, per molti anni collaboratrice fissa di quotidiani e periodici per rubriche di critica teatrale e cinematografica, è vice-direttore della rivista online di teatro, cultura e politica Scenario. Collabora da oltre vent’anni con la Rai nei programmi di intrattenimento. Vive e lavora a Roma.
Doriano Fasoli: Un’antologia di centodieci poesie di autori contemporanei poco conosciuti al grande pubblico. Perché vengono definiti «leopardisti» e non «leopardiani»?
Cinzia Baldazzi: Nessuno alla morte del poeta romantico è stato mai ritenuto o ha inteso essere «leopardiano», né avrebbe potuto accadere, come si determina in tutti i poeti che non siano semplicemente – si fa per dire – elementi di una scuola poetica globale, come ad esempio gli «ermetici» Alfonso Gatto e Piero Bigongiari. Nessuno, ovviamente, ha più scritto come Gatto e Bigongiari, per motivi che riguardano l’irripetibilità dello spazio-tempo nei campi del pensiero e della comunicazione umana. Tuttavia, il filo rosso della poesia ermetica, che unisce, ad esempio, questi due grandi autori, può far sì che di costoro esistano più o meno diretti successori, prosecutori. Ma per poeti che sono il Romanticismo, come Leopardi, o il Decadentismo, come D’Annunzio (ambedue considerati slancio creativo nato in Italia), ispirarsi a loro coincide con un’affinità subliminale o espressa che necessariamente corre per altre strade. Così il dannunzianesimo è stato forte nel Novecento, ma né Ungaretti né Montale, nella loro alternativa condizionata, possono essere considerati dannunziani.
Cosa intendiamo allora per «leopardisti»?
Partiamo dal capofila della prima generazione, ovvero Giuseppe Ungaretti, che in Orme poetiche viene ‘riproposto’, sempre con le mediazione leopardiana, dalla poesia «Saro» di Salvatore Armando Santoro. Si è parlato di molte affinità tra l’infinito leopardiano e quello ungarettiano. Leopardi ha còlto, ha intuito l'infinito spaziale, visto nella negazione della realtà fisica a cui era da sempre abituato: spazi interminati, silenzi sovrumani, quiete profondissima. Una dimensione impossibile da paragonare con quella ‘solita’, ‘abituale’. Per Ungaretti, l’assoluto cui l'uomo tende è per definizione indicibile, inesprimibile, in quanto trascende la capacità umana di espressione. Però, l’essenzialità della parola risponde all’esigenza di dare voce al mistero dell'assoluto nascosto in ogni uomo.
Dunque nel Novecento facciamo un passo avanti.
Il fluire del tempo nello spazio romantico apre la strada a quello ungarettiano e ne esce configurato in forma non misurabile, ma propria dell’uomo. Le «orme poetiche» lasciate da Ungaretti evocano un infinito una volta leopardiano, oggi leopardista: suo alle origini, ieri ungarettiano, oggi nostro. Come nella già citata «Saro» di Santoro, storia davvero leopardiana, con la chiusa dedicata a coloro i quali «aspettano ancora il dì di festa», ma con l’emblema umano dell’assenza, delle passate stagioni che tornano nel ricordo vivo, ineffabile ma adesso misurabile, perché il giovanissimo Saro sedeva con lui, con gli amici, accanto alla chiesa, e le sue siepi le aveva già valicate.
Nella tua lunga introduzione, la parte dedicata a ciascun poeta è avviata da un brano di prosa leopardiana che poi, continuando nella lettura, fa da guida, da traccia all’analisi del singolo autore.
È indubbio come esista, e la critica lo ha rilevato da tempo, una sorta di affinità elettiva in atto tra il pensiero di Giacomo Leopardi e molti poeti del nostro Novecento: Ungaretti, Montale, Bigongiari, Zanzotto, Sergio Solmi. È la cosiddetta «prima generazione» di leopardisti. Nel mio saggio introduttivo ho preso le mosse da questo «lascito» del secolo appena concluso, per leggere sotto una simile luce i poeti degli anni Duemila e identificare gli undici autori di Orme poetiche in una «seconda generazione» di leopardisti.